“Uri” di Kamel Daoud, un grido silenzioso tra memoria, dolore e libertà
L'angolo del libro, recensione Paolo Rausa
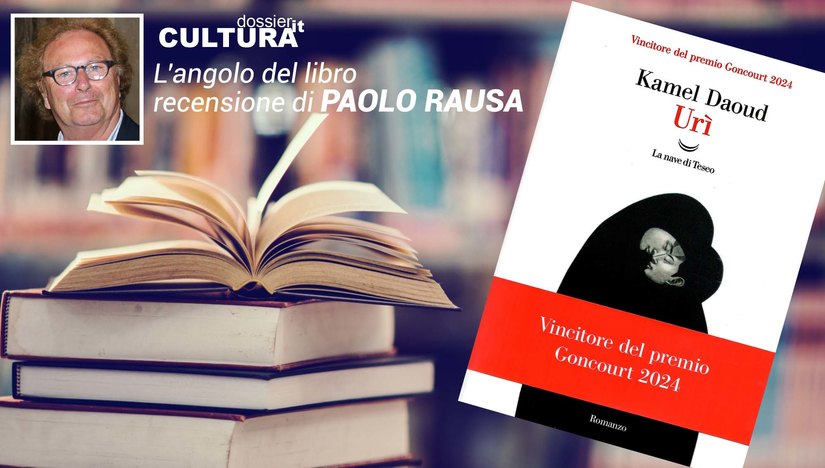
Il nuovo romanzo di Kamel Daoud, “Urì”, è arrivato in Italia martedì 17 giugno 2025 per La nave di Teseo (traduzione di Simona Mambini, pp. 448, euro 22). Nato a Mostaganem il 17 giugno 1970, un bel regalo per il suo compleanno da parte di una Editrice attenta nell’in/seguire i casi letterari più importanti e significativi del nostro tempo. Tale è il romanzo di Kamel Daoud che ora vive in Francia, esule, algerino del Mediterraneo, la sua vera patria. L’antica provincia romana d’Africa e la Namibia di Giugurta, la sua capitale Cirta/Costantina arredata di striscioni quando la visitammo nel 1986, antifrancesi. Ricordavano, come sulla facciata del Comune di Usurbil nei Paesi Baschi “Indipendencia”, la lotta dei popoli per l’autonomia e la determinazione.
Per noi, cugini dei francesi di cultura e di fisionomia, era difficile separare le nostre esperienze e responsabilità dalle loro e il più delle volte ci affidavamo alla canzone di Toto Cutugno “L’italiano”. Lasciatemi cantare, sono un italiano vero, intonavamo anche nella casba di Algeri, ospiti di una famiglia mista, lui arabo islamico lei berbera. Andavano d’amore e d’accordo. Nei vicoli e nei dedali del centro storico i segni de “La Battaglia di Algeri”, girata da Gillo Pontecorvo nel 1966. Appena in tempo a sfuggire alla guerra civile, la fitna, fra le Istituzioni che rappresentavano il pilastro ideologico della nuova Algeria, rappresentate dal FLN, e le nuove istanze islamistiche dei Fratelli musulmani che aspiravano qui come in tutto il Maghreb e oltre a imprimere il sigillo religioso alla vita civile. Cominciarono le stragi dall’una e dall’altra parte, vittime i civili che subivano le accuse di poca convinta adesione alle prescrizioni del Corano e perciò massacrati e derubati di tutto con lo sfregio delle decapitazioni all’istante e dall’altra da parte dei soldati di un esercito allo sbando che accusava i poveri abitanti dei villaggi di tradimento e che perciò venivano deportati a marcire nelle patrie galere di Algeri.
Dal 1992 al 2002, tanto durò la guerra intestina che produsse stragi e distruzioni e la morte di 250 mila algerini, fra cui donne e bambini. Solo nell’ultimo anno, il 31 dicembre, perirono almeno mille poveri contadini di una decina di villaggi in cui Kamel Daud ambienta questa storia, drammatica e pure necessaria, non per polemica giornalistica ma per amore della verità e della libertà. La guerra si concluse con una legge che offriva l’amnistia e anche una somma riparatrice a tutti i terroristi, purché dichiarassero di aver svolto le mansioni di cuochi. Incredibile! Ai soli uomini peraltro e non alle donne, che pure erano state rapite, trattate come schiave, utilizzate per i lavori domestici e per soddisfare i desideri della carne. La legge della Riconciliazione, dell’oblio, così definita. Che ha una sua giustificazione storica e sociale, la stessa che venne imposta da Zeus ad Ulisse/Odisseo quando era sceso in armi pronto per contrastare la reazione dei parenti dei proci. Lo ricorda Omero, quando con una saetta Zeus impone il suo volere convincendo Ulisse a soprassedere e a sottoscrivere il patto non della dimenticanza, ma dell’oblio appunto, l’unica modalità per consentire alla società di riprendere il cammino insieme.
Ma questo non voleva dire nascondere il passato, semmai occorreva fare luce per denunciare gli abusi e gli errori perché non si reiterassero ancora per l’avvenire. Kamel Daoud affida ad una splendida ragazza di 26 anni circa dagli occhi verdi smeraldo il racconto della sua condizione, vittima insieme alla sorella di una incursione degli islamici che al culmine del loro furore le avevano sgozzate. Lei per il colmo della s/fortuna si era salvata dopo un intervento delicatissimo in ospedale ma le erano rimasti a monito i segni nel taglio che aveva reciso le corde vocali e la giugulare. Il vuoto era stato riempito da una cannula che aveva lo scopo di consentire l’alimentazione. Alba era stata chiamata dalla madre Khadija la ragazza che all’età di 5 anni era rinata a seconda vita. Non si erano mai arrese e anzi la madre cercava l’intervento di qualche chirurgo europeo, un luminare che potesse ridare la voce alla fanciulla che intanto aveva preso a vivere in modo aperto e senza condizioni imposte dall’imam e dalla società algerina che perpetuava alle donne le discriminazioni nei ruoli sociali e professionali. Lei invece ne derideva in qualche modo gli usi e i costumi.
Aveva aperto ad Orano, dove viveva, un negozio di parrucchiere, una specie di salone di bellezza, di fronte alla moschea, una vera e propria mancanza di rispetto secondo l’imam e i benpensanti che nel corso di una reazione lo devastarono per impedire la presenza provocatrice di questo esercizio. Approfittando del viaggio della madre a Bruxelles, Alba nel frattempo incinta decide di compiere un percorso alla ricerca delle sue radici e interrogare così i resti della sorella Taïmoucha, nel villaggio natale in montagna. Le avrebbe chiesto se la creatura che aveva in pancia e a cui aveva dato nome Urì, come le vergini che abitano il Paradiso islamico, dovesse vivere o, sottoponendosi all’aborto, neppure farla venire alla luce. Quel viaggio sui mezzi di fortuna è risolutivo. Alba incontra dei personaggi che definiscono la storia del paese per le violenze subite: Aïssa, un libraio ambulante che è costretto a portare in giro sul camioncino nei vari paesi e villaggi per rifornire le librerie solo volumi di natura religiosa e di ricette e alimentazione. Gli era stato proibito di vendere altre opere contrarie alla religione e allo Stato, uniti in una santa alleanza contro la libertà e la diffusione della cultura.
Aveva i
segni della violenza subita da lui e da tutta la famiglia nella gamba colpita
da un colpo di fucile e ne faceva pubblica dimostrazione dal momento che nessuno
lo riconosceva perché era vietato riprendere argomenti che erano incardinati e
irrisolti nel recente passato. Così come anche la confessione di “una
terrorista”, la rossa cosiddetta, Hamra, una bellissima giovane dai
lunghi capelli fluenti, rapita e stuprata, violentata e poi sposa forzata più
volte e madre di nuove vite a cui si sentiva estranea. Terminata la guerra
civile, nessuno si preoccupava di lei che non trovava lavoro e non riusciva a
sopravvivere. Questo il lascito della guerra decennale intestina. Alba non si
dà per vinta, continua il suo dialogo con la figlia Urì per renderla partecipe
dei suoi drammi e anche delle sue speranze, finché non raggiunge il suo
villaggio ora abbandonato dai pochi superstiti ed entra in un dialogo
immaginario con i resti mortali della sorella, attribuendosi dapprima le colpe
dalla sua uccisione ma poi accettando la sua condizione e il suo ruolo di
testimonianza della verità. In questo senso Alba rappresenta lo spirito
indomito dell’arte e della letteratura che non si lascia sedurre e imbrigliare
e che rivendica la necessità di fare chiarezza sul passato per poter
reimpostare un rapporto corretto per l’avvenire. Lo dobbiamo a coloro che, come
Urì, si affacciano alla vita. Kamel Daoud è stato vincitore del premio Goncourt
2024.
Paolo Rausa
Titolo originale: Houris
Autore: Kamel Daoud
Traduttore: Simona Mambrini
Editore: La nave di Teseo, collana Oceani
Anno edizione italiana: 2025 (disponibile in libreria dal 17 giugno 2025)
Formato: Brossura
Pagine: circa 448
ISBN/EAN: 978-88-346-2029-8
Prezzo indicativo: circa € 20–22
Compralo subito su Amazon € 20,90
Formato Kindle € 11.99
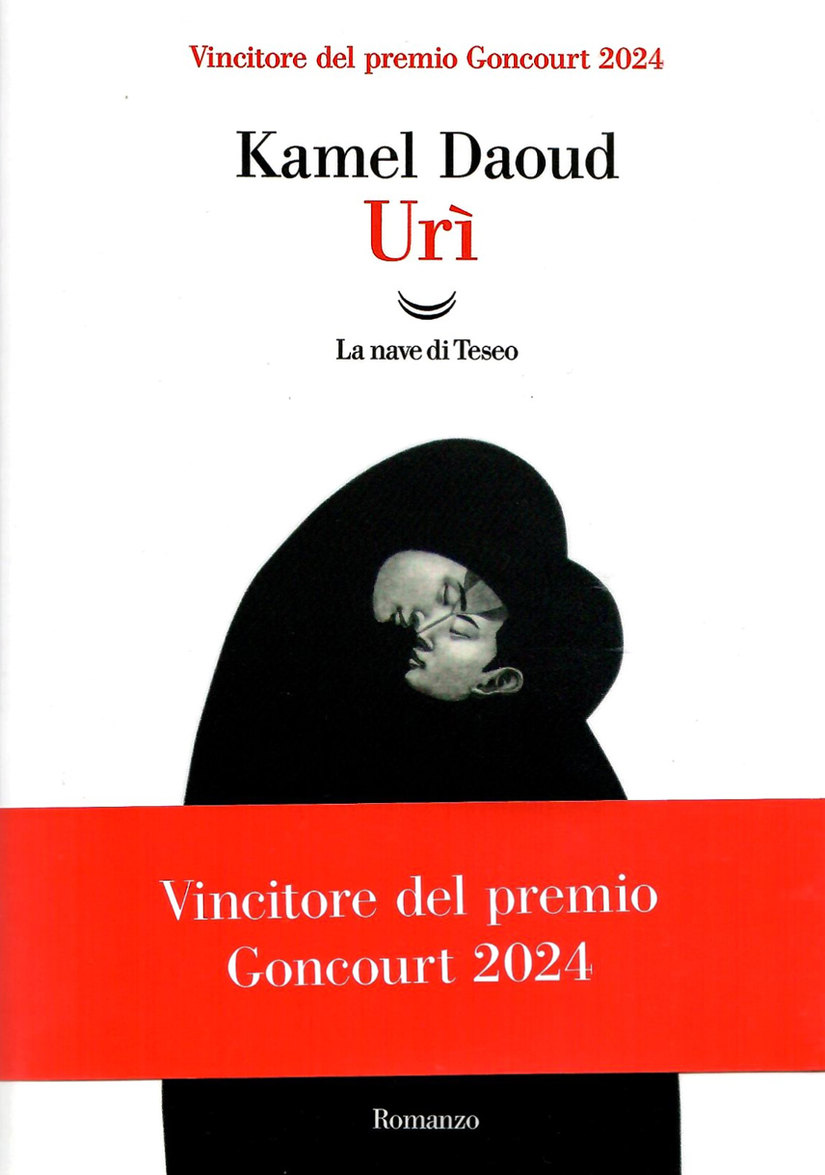
 Ascolta Radio Free Music
Ascolta Radio Free Music  Pubblicità
Pubblicità 













