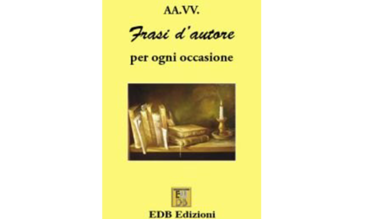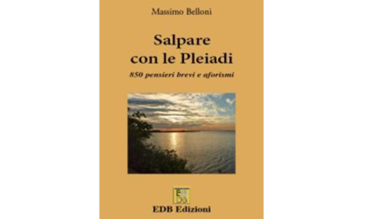1924 America: note rivoluzionarie
Anni 20, il suono dell'America sbarcò in Europa, e insieme ad un giovane autore americano timido ed impacciato scoprì un continente esausto e vecchio, che non poteva più inventare niente. Gershwin vs Ravel e Satie, cronaca di un cambiamento epocale

Se parli di politica, arte, vita o storia, la sostanza del progredire è sempre stato il nuovo, un diverso, che si contrappone ad un vecchio, un omologato.
Il 12 febbraio 1924, quando il concerto per pianoforte ed orchestra di Gershwin debuttò, entusiasmò New York, ma non la strabiliò. Quelle melodie erano una sublimazione ma nulla di rivoluzionario o di diverso da quello che Broadway, già da tempo, aveva sotto gli occhi. Poi quelle note “giovani” doppiarono il sentiero delle migliaia di “yankees” sbarcati in Europa a cambiare l’inerzia di una guerra mondiale. E i suoni dell’Eolian Hall piombarono violenti sul “vecchio” continente, lacerando il cuore di una cultura esausta.
La “Rapsodia in Blue” parve subito una svolta culturale, una rivoluzione che riempiva con “suoni” nuovi, orizzonti di stanchezza. Già. il nuovo. Quel clarinetto improvviso che si impone netto, preciso, e disegna il silenzio di un timbro così diverso dai precedenti. E poi, nuova, è anche la roba che gli viene dietro. L’incedere turbolento dell’orchestra, mischio di umori vincenti e positivi quanto l’America lo è di razze. Perché la rapsodia sbarcata dai trasatlantici sull’Europa di Weimar, si portava addosso il fiato, il sudore, il dramma, la potenza e la forza di un popolo intero. Il lamento dei campi di cotone, l’alito incandescente dell’industria e le luci sfarzose di Broadway, un miscuglio di sensazioni ed odori unici, un urlo di abbagliante novità. Note orchestrali, ma anche emblemi di un genio colonizzatore, verso elettrico di un dominio culturale ed economico che andava manifestandosi su un continente stanco e in penombra, un albergo malinconico di splendori in disuso, in cui lo sfarzo era solo abbandono d’una prospettiva futura.
Il 1928 racconta di un George Gershwin, ricco ma intimidito, sbarcato a Parigi. Voleva imparare, dove gli sembrava si dovesse imparare. Uscì deluso dall’incontro con Ravel: “George, io non ho nulla da insegnarle. Lei diventerebbe un Ravel di seconda mano mentre, voi, siete già un Gershwin di prim’ordine.” Parole che testimoniavano allo statunitense (la cui musica incarnava il sapore che dava l“America” ad ogni un immigrato) che le sue note non erano provincia, e neanche repertorio ma un “nuovo” che inesorabile si imponeva. In pratica George a Parigi si trovò a marciare con lo stesso passo impacciato ma deciso delle armate statunitensi che nel 1917 aggirandosi nelle retrovie in estenuanti esercitazioni, avevano deciso con un peso industriale (più che militare) il destino di una guerra in stallo.
Quei mesi del 1928 per George Gershwin furono la scoperta di una cultura dimessa, e chissà nelle lunghe passeggiate per le strade della “Ville Lumiere” quante volte avrà rasentato non solo simbolicamente le due stanze messe fra Montparnasse e il Quariere Latino che l’ex proprietario-musicista francese chiamava armadio. Perchè la grandezza musicale d’Europa, allora, non offriva la ricchezza di Broadway, i grand hotel, le feste, la fama sociale che George viveva, ma la malinconia folle di due locali e l’abbandono di ogni poesia “Vado a dormire nel mio armadio” diceva all’alba Erik Satie, camminando incerto verso le sue stanze bohemienne. Un ambiente povero, dimesso, elette a suo rifugio da uno degli ultimi innovativi, compositori europei. Non si incontrarano, Gershwin e Satie, d’altra parte erano gemme di due mondi diversi, finestre aperte su paesaggi di opposti emisferi. Satie. Folle ricciolo creativo di un’Europa che nel nuovo secolo si era rivelata imbellettata, pettinata e composta alla maniera belle epoque. Un continente fermo, che aspettava inesorabilmente con il suo acciaio l’appuntamento fra i campi di Verdun. Erik Satie era nato oltre metà ottocento. Un bambino irrequieto, vivace, strano, portato alla musica per inquadrare le sue stramberie ma che utilizzò le note come espressione della sua vena folle. Creò di tutto, Satie, ma la sua melodia, anche nei versi più ridondanti e futuristi (macchine da scrivere, colpi di pistola, motori) fu comunque una espressione del tutto intima e solitaria, magari anche strillo, ma sempre impersonificazione di un dandy testardo e silenzioso, provocatorio e collerico, ma comunque solo dentro un ‘Europa spenta di ogni vitalità. Insomma (per quanto ci si possa rammaricare o rallegrare sia andata così) il ventesimo secolo (non solo nella musica) fu quello che vide la colonizzazione economica e culturale degli Stati Uniti verso l’Europa. Il giovane che annichilì il vecchio come, in natura, è sempre stato logico fosse. Oggi, ancora non è così. Domani, chissà!
Il 12 febbraio 1924, quando il concerto per pianoforte ed orchestra di Gershwin debuttò, entusiasmò New York, ma non la strabiliò. Quelle melodie erano una sublimazione ma nulla di rivoluzionario o di diverso da quello che Broadway, già da tempo, aveva sotto gli occhi. Poi quelle note “giovani” doppiarono il sentiero delle migliaia di “yankees” sbarcati in Europa a cambiare l’inerzia di una guerra mondiale. E i suoni dell’Eolian Hall piombarono violenti sul “vecchio” continente, lacerando il cuore di una cultura esausta.
La “Rapsodia in Blue” parve subito una svolta culturale, una rivoluzione che riempiva con “suoni” nuovi, orizzonti di stanchezza. Già. il nuovo. Quel clarinetto improvviso che si impone netto, preciso, e disegna il silenzio di un timbro così diverso dai precedenti. E poi, nuova, è anche la roba che gli viene dietro. L’incedere turbolento dell’orchestra, mischio di umori vincenti e positivi quanto l’America lo è di razze. Perché la rapsodia sbarcata dai trasatlantici sull’Europa di Weimar, si portava addosso il fiato, il sudore, il dramma, la potenza e la forza di un popolo intero. Il lamento dei campi di cotone, l’alito incandescente dell’industria e le luci sfarzose di Broadway, un miscuglio di sensazioni ed odori unici, un urlo di abbagliante novità. Note orchestrali, ma anche emblemi di un genio colonizzatore, verso elettrico di un dominio culturale ed economico che andava manifestandosi su un continente stanco e in penombra, un albergo malinconico di splendori in disuso, in cui lo sfarzo era solo abbandono d’una prospettiva futura.
Il 1928 racconta di un George Gershwin, ricco ma intimidito, sbarcato a Parigi. Voleva imparare, dove gli sembrava si dovesse imparare. Uscì deluso dall’incontro con Ravel: “George, io non ho nulla da insegnarle. Lei diventerebbe un Ravel di seconda mano mentre, voi, siete già un Gershwin di prim’ordine.” Parole che testimoniavano allo statunitense (la cui musica incarnava il sapore che dava l“America” ad ogni un immigrato) che le sue note non erano provincia, e neanche repertorio ma un “nuovo” che inesorabile si imponeva. In pratica George a Parigi si trovò a marciare con lo stesso passo impacciato ma deciso delle armate statunitensi che nel 1917 aggirandosi nelle retrovie in estenuanti esercitazioni, avevano deciso con un peso industriale (più che militare) il destino di una guerra in stallo.
Quei mesi del 1928 per George Gershwin furono la scoperta di una cultura dimessa, e chissà nelle lunghe passeggiate per le strade della “Ville Lumiere” quante volte avrà rasentato non solo simbolicamente le due stanze messe fra Montparnasse e il Quariere Latino che l’ex proprietario-musicista francese chiamava armadio. Perchè la grandezza musicale d’Europa, allora, non offriva la ricchezza di Broadway, i grand hotel, le feste, la fama sociale che George viveva, ma la malinconia folle di due locali e l’abbandono di ogni poesia “Vado a dormire nel mio armadio” diceva all’alba Erik Satie, camminando incerto verso le sue stanze bohemienne. Un ambiente povero, dimesso, elette a suo rifugio da uno degli ultimi innovativi, compositori europei. Non si incontrarano, Gershwin e Satie, d’altra parte erano gemme di due mondi diversi, finestre aperte su paesaggi di opposti emisferi. Satie. Folle ricciolo creativo di un’Europa che nel nuovo secolo si era rivelata imbellettata, pettinata e composta alla maniera belle epoque. Un continente fermo, che aspettava inesorabilmente con il suo acciaio l’appuntamento fra i campi di Verdun. Erik Satie era nato oltre metà ottocento. Un bambino irrequieto, vivace, strano, portato alla musica per inquadrare le sue stramberie ma che utilizzò le note come espressione della sua vena folle. Creò di tutto, Satie, ma la sua melodia, anche nei versi più ridondanti e futuristi (macchine da scrivere, colpi di pistola, motori) fu comunque una espressione del tutto intima e solitaria, magari anche strillo, ma sempre impersonificazione di un dandy testardo e silenzioso, provocatorio e collerico, ma comunque solo dentro un ‘Europa spenta di ogni vitalità. Insomma (per quanto ci si possa rammaricare o rallegrare sia andata così) il ventesimo secolo (non solo nella musica) fu quello che vide la colonizzazione economica e culturale degli Stati Uniti verso l’Europa. Il giovane che annichilì il vecchio come, in natura, è sempre stato logico fosse. Oggi, ancora non è così. Domani, chissà!